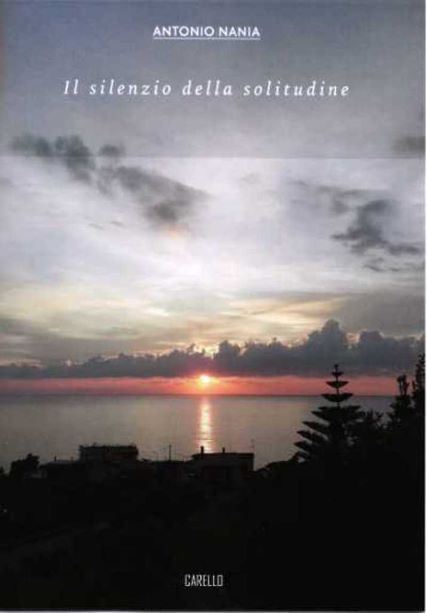Un’antica pratica sempre attuale: menti ottenebrate da una lucida follia rinunciano alla vita

Oggigiorno, purtroppo, sono divenuti sempre più frequenti i casi di suicidio, all’interno di una società spesso cieca e sorda dinnanzi a delle esigenze che a volte non riescono a trovare altra via d’uscita, se non la fine della vita. Ma perché proprio questa? E, soprattutto, cosa c’è realmente dietro?
Tra le svariate metodologie utilizzate per dare una fine alla routine giornaliera, se ciò non avviene a causa di qualche malanno o per l’età avanzata, l’uomo ha “pensato bene” di estremizzare una normalità come la morte, rendendola precoce e drastica. Il suicidio non è novità contemporanea, ma testimonianze e decessi famosi attestano la spassionata predisposizione per questo inusuale atto sin dai tempi più remoti.
Pungolo dell’attività letteraria del Trecento, il suicidio conquista anche l’attenzione di Dante e Boccaccio, i quali dedicano alla tematica una piccola parentesi nelle loro celeberrime opere. Dall’attività dantesca – nella prima cantica della Divina Commedia – vengono riprodotte suggestive descrizioni e avvincenti dialoghi caratteristici del girone dei violenti, ambito successivo ai cerchi dei peccatori intemperanti. Tra costoro è possibile riconoscere il notaio della corte di Federico II di Svevia, Pier delle Vigne. Dante condanna un uomo politicamente dipendente, troppo attento agli affari dell’imperatore per poter dedicare del tempo alla propria fede e vittima dell’andamento unidirezionale seguito durante la propria esistenza. Diventa così un fantoccio il cui destino appartiene alle mani di un marionettista dispotico, l’unico a poter dare un senso alla vita di un essere inanimato.
La durezza con la quale Pier delle Vigne punisce se stesso dimostra quanto sia preferibile assoggettarsi ad una pena piuttosto che provare a far valere le proprie tesi confrontandosi con il prossimo. La pecca del notaio è univocamente quella di appartenere ad una società uniforme ed affetta da cecità che giudica e condanna impulsivamente, una collettività per niente differente da quella contemporanea, che mira a reprimere ogni tipo di difformità perché potenzialmente contrapposta a qualsiasi attività conformista.
Ѐ frutto dell’ingegno di Boccaccio una particolare novella tratta dal Decameron, appartenente alla V giornata. L’amore è il fulcro di questa narrazione, simbolo dell’ottenebramento cui va incontro l’uomo perdutamente innamorato; Guido degli Anastagi è indotto al suicidio, sorte che, probabilmente, avrebbe leso anche Nastagio degli Onesti se non avesse deciso tempestivamente di allontanare da sé la causa della sua tristezza, una donna disdegnosa tanto da privarlo di uno sguardo. Lontano dalla figlia di Traversaro, vagando per una pineta boscosa, Nastagio assiste al corteggiamento della donna, in vita, da parte di Guido degli Anastagi . La donna, mentre transita dalla dimensione terrena a quella ultraterrena, cambia movenza e da una profana carnefice diventa una creatura animosa ed indifesa. Essa, avendo condotto un uomo alla morte, non merita altro che eterno tormento, un capovolgimento dei ruoli rilevante che la vede costretta a sottostare alla volontà divina e alle sevizie di colui che, oltrepassati i confini dell’amore, riserba nient’altro che odio.
Una concezione validamente posta una spanna sopra il volgo per l’intenzione di condannare, ad una morte fredda e stazionaria, la responsabile della spossatezza mentale del sedotto. I due autori percepiscono l’atto differentemente e ciò si deve alla diversa influenza dell’ambiente circostante, prettamente ecclesiastico nel primo caso ed estremamente laico nel secondo. Il punto d’incontro tra le due concezioni è rappresentato dal complesso di inferiorità e dalla negatività con la quale si affronta il respingimento messo in atto da chi si desidera.
Cosa concretamente pensa l’individuo che propende per la strada del non ritorno? La risposta è semplice: non pensa; abituato a soggiacere al volere altrui, non è più in grado di decidere per se stesso e tale difficoltà degenera, nell’istante in cui è colto da una fulminea instabilità mentale, in quell’oblio eccellentemente rappresentato dalla morte. Questa è sollecitata da irrazionalità, rifiuto sociale e scarso amore per la propria persona. Si considera vana la propria esistenza per la mancanza di ambizioni e stimoli e per una sempre meno efficiente comunicazione interpersonale che rappresenta la tendenza all’introversione.
La mente del venturo suicida è caliginosa ed intorbidita da un tedioso senso di solitudine e dall’erronea convinzione di essere uno sbaglio e un fardello sociale destinato all’emarginazione. Alla base di una tragedia simile c’è sempre l’incompatibilità fra la vittima e la collettività. Quest’ultima si contraddistingue per la scarsa empatia e per l’incapacità relazionale e comunicativa, a vantaggio dell’opposizione aprioristica all’eterogeneità. Gli occhi del soggetto in esame mentono, percepiscono ciò che vedono come impeccabile fino a che, davanti a uno specchio, tutto diventa imperfetto. Vede le persone dialogare, scherzare e scambiarsi affetto, ignorando che “non è tutto oro quel che luccica” e, soprattutto, che il dissapore “non guarda in faccia a nessuno”. Ironia della sorte, la debolezza è più forte della potenza e prevale in ogni caso; perciò, anticipando la vigliaccheria, si affronta con maggior coraggio la morte.
Il suicida cura maniacalmente ogni dettaglio, sceglie attentamente la sua sorte e la immagina nell’avvenire, valuta frequentemente ciò che sta progettando, si interroga circa il dolore che il suo gesto potrebbe apportare ai propri “cari”, ma li vede impegnati ad ignorarlo e conferma, ancora una volta, di preferire il sonno eterno. La gente si diverte a trascurare un individuo quando è presente per poi poterlo rimpiangere con gusto quando non si ha più l’opportunità di trascorrere del tempo insieme. Ѐ risaputo che la morte, in generale, tende ad impietosire e addolcire gli animi di tutti. Il tormento che dovrebbe ledere moralmente coloro che rappresentano il male per la società è quello di vivere con arroganza e complesso di superiorità.
L’odio per la comunità si converte in odio per se stessi. L’adrenalina accumulata fuoriesce ed è così possibile che la paura di compiere un salto nel vuoto, di premere un grilletto o di penzolare avvinghiati ad una fune, sia pari a zero. Ѐ così ragionevole pensare all’insensata necessità di continuare a far battere il proprio cuore una volta morti psicologicamente. Tutto ciò di cui avrebbe bisogno l’uomo sarebbe il preludio della felicità, ma è più semplice che si trovi un motivo in più per freddare se stessi piuttosto che un pretesto da cui partire, per trovare la forza di far procedere la propria vita.
Alessandra Crispo
Nell’Inferno di Dante Alighieri i suicidi sono collocati nel secondo girone del settimo cerchio, dove sono puniti i violenti contro sè stessi, e trasformati in piante, forma di vita inferiore, perché essi hanno rifiutato la loro condizione umana uccidendosi.
Dante, ignaro, pensando che fossero alberi, “coglie” un ramicello da un grande arbusto e viene sorpreso dal grido “Perché mi schiante?” seguito dal fuoriuscire di sangue marrone dal punto reciso. Di nuovo arrivano parole dalla pianta “Perché mi scerpi? / non hai tu spirto di pietade alcuno? / Uomini fummo, e or siam fatti sterpi” Eravamo uomini e ora siamo piante, perciò la tua mano dovrebbe essere più clemente“. Al che Dante impaurito lascia subito il ramo.
Nella foto: incisione di Paul Gustave Dorè, Il girone dei suicidi